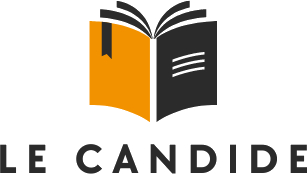Storicamente il Forte di Ceva ha rappresentato negli anni un’importante testimonianza nel campo dell’architettura militare. Un tempo fu però anche un esempio di resistenza a Napoleone ed ai francesi.
Già perché nel corso di quel 1796 che la Campagna d’Italia francese sconvolse fu l’ultimo baluardo a cadere.
Nonostante la fine delle ostilità fosse stata sancita il 28 aprile 1796 con l’Armistizio di Cherasco che stabiliva lo sgretolamento del regno sabaudo e la piena vittoria francese, il forte di Ceva, governato da Francesco Bruno Tornaforte, si difendeva, nonostante il dispiegamento delle forze di Napoleone. Tornaforte era deciso a non abbandonare il fortino nonostante le richiesta di resa e si rifiutò a più riprese di cedere anche dopo l’armistizio. Così fu necessario l’intervento di Re Vittorio Emanuele perchè il forte fosse consegnato ai Francesi, senza essersi mai formalmente arreso.
L’imponenza del sito e la sua doppia natura militare e religiosa lo hanno reso comunque un bene di notevole interesse culturale ed un simbolo per l’intera area cebano monregalese almeno sino al 1801, anno della definitiva demolizione definitiva avvenuta nel 1801 ad opera dell’esercito napoleonico. Al di là dei temi di stretta attinenza strategico militare è comunque importante ricordare come questa costruzione abbia per lungo tempo rappresentato una sorta di Guantanamo ante litteram sabaudo dove venivano ospitati coloro che avevano minacciato l’incolumità e la sicurezza della casa sabauda. Una misura punitiva, ma anche preventiva che veniva applicata a “buona ragione” anche ai familiari dei sospettati o dei rei, più o meno confessi. Questo viene dedotto scorrendo numeri e note di un censimento ordinato nel 1718 Vittorio Amedeo II, che una vasta inchiesta per stabilire le condizioni delle carceri di Stato.
In buona sostanza si trattava della prima fase di un’indagine che negli anni successivi si sarebbe estesa anche alle carceri comunali e ad alcuni luoghi di reclusione controllati dalle giurisdizioni signorili. Fra i documenti sopravvissuti ci sono le Relations des prisons qui se trouvent actuelment en estat de service dans le fort de Ceve, grandes, petites, leurs situations et par qui elle sont occupées avec leur nom separées che illustravano, fra l’altro, la disposizione delle celle nel forte di Ceva e la dislocazione dei prigionieri.
Quella di Ceva, in particolare, pur non essendo meno imponente e strategicamente importante delle altre strutture fortificate sabaude costruite lungo l’arco alpino (soprattutto Exilles, la Brunetta, Fenestrelle), era percepita più come un fortezza di detenzione che come fortte militare
Le prigioni destinate ai prigionieri di Stato si trovavano nel quartiere del comandante ed erano cinque: La Saggezza, capace di contenere due letti, ma poco sana per esser situata sopra la rocca; La Costanza, capace di due letti, ma bisognosa “d’esser rinforzata da una parte per esse più sicura”; La Speranza, con un’anticamera, ciascuna capace di un letto; La Pazienza, capace d’un letto separata dalle due suddette con un semplice muro; La Penitenza, «capace di due letti, ma poco sana, bisognosa “d’esser rinforzata per esser più sicura
. Di queste cinque prigioni, solo le prime tre erano occupate. Nel quartiere nuovo dei soldati della guarnigione di stanza a Ceva, si trovavano, invece, i prigionieri ad correctionem. Le Relations puntualizzavano che le celle destinate a questi ultimi non erano di fatto “ben sicure”.
A completare il quadro degli spazi del forte destinati alla reclusione erano, infine, “tre crottoni scavati nella rocca”, che, scriveva il comandante, risultavano altrettanto poco sicuri per la facilità che offrivano ai prigionieri «di fuggirsene per le vene arenose della rocca».
Al momento della stesura di questa descrizione i prigionieri di Stato erano tre ed altrettanti i reclusi ad correctionem. Con questo termine mi riferisco ai giovani – per lo più fra i quindici e i trent’anni –la cui reclusione era richiesta al sovrano direttamente dai genitori o dai tutori. La storiografia francese ha insistito sull’importanza di tale fenomeno sociale e disciplinare nelle strategie di difesa dell’onore familiare. Penso soprattutto ad alcuni recenti studi di Arlette Farge11 e di Brian E. Strayer12, ma il problema era già stato colto da Frantz Funck Brentano (1862-1948), a cui si devono indagini pionieristiche sulle lettres de cachet e sul loro ruolo nella vita delle famiglie d’antico regime13.
La procedura era quasi sempre la stessa. Il capofamiglia si rivolgeva al governatore della provincia in cui risiedeva chiedendo la reclusione del figlio in una fortezza dello Stato; il governatore a sua volta trasmetteva la richiesta alla Segreteria di Stato agli Affari Interni unendovi riflessioni personali. Di norma l’assenso per l’arresto giungeva dopo pochi giorni: il sovrano inviava un ordine al governatore; il corpo di guardia si recava allora dal giovane, lo arrestava e lo conduceva in fortezza. Qui il detenuto era destinato a restare in cella sino a quando i genitori non ne avessero chiesto la liberazione.
Nonostante le autorità non favorissero questa pratica, nel corso del secolo il numero dei detenuti ad correctionem continuò a crescere.
“Li prigionieri ad correctionem”, scriveva nel 1750 il segretario degli Interni conte Saint Laurent, «devono restar sempre racchiusi in carcere»; la detenzione in fortezza non avrebbe cioè dovuto consentire alcun contatto con altri prigionieri o con ufficiali militari e civili. «La detenzione nel forte», spiegava sempre Saint Laurent, sarebbe servita come «penitenza de’ passati trascorsi, affine di … emendare la vita». A questo proposito nel 1761 si espresse lo stesso Carlo Emanuele III, non ritenendo che reclusioni di tal genere dovessero superare i sei mesi di durata.
Tornando al forte di Ceva un decennio dopo l’indagine del 1718, il numero dei reclusi era triplicato. Secondo uno Stato de’ prigionieri che sono detenuti nel forte di Ceva, nel 1729 vi erano, infatti, rinchiusi 16 prigionieri
Comunque a testimonianza della severità dell’ambiente ci vengono in soccorso alcuni scritti di personaggi che per motivi diversi vi hanno soggiornato come ospiti o guardiani
. E’ il caso ad esempio del cavalier Umberto Cousani (Ubert de Cousany), un membro della corte di Vittorio Amedeo II, di cui era ancora lontano cugino. Non sono chiare le ragioni della sua reclusione nella fortezza dal 1708. Da ciò che però si desume da una lettera del 1727 del comandante del forte cavalier François Nicolas de Bellegarde de Nangy non doveva passersela molto bene le sue condizioni vengono definite pessime e lo stato di salute che si soffermava anche sul si soffermava sul regime alimentare di Cousany, “tojours en desordre”.
La corrispondenza stesa da Bellegarde informa puntualmente sul peggioramento della condizione del detenuto, immobilizzato a letto da “une malatie scorbutique inveterée presque incurable”, che lo portò alla morte nel gennaio 1730.
Oppure del marchese Carlo Costanzo del Carretto di Monforte che aveva guidato la popolazione del feudo di Monforte in una dura lotta contro i funzionari ducali in difesa dei propri privilegi. Il marchese non aveva poi esitato ad opporsi alle truppe ducali “conducendo non tanto un atto di insubordinazione militare quanto una tipica insurrezione di tipo signorile e fiscale”. Arrestato nel 1694, impazzì nel corso della detenzione in carcere, morendo in quello stesso anno.

Un altro prigioniero di Stato era Carlo Francesco Cochis. In realtà questi era stato arrestato nel 1723 su richiesta della madre Angelica, che si trovava a corte da quasi quarant’anni come “fama”, o nutrice, dei principi, i figli e le figlie di Vittorio Amedeo II, il quale aveva accettato di sostenere la detenzione “a spese delle sue finanze”. E questo perché? . Si trattava di un tipo di detenuto sui generis, rinchiuso per ragioni disciplinari come accadeva a diversi giovani.
Ed ancora l’allora ventenne cavalier Filippo Ferdinando Grimaldi, arrivato da Cuneo il 16 febbraio 1728. Questi era membro di una importante famiglia genovese che si era stabilita a Cuneo già a fine del Cinquecento (suoi esponenti avevano preso parte al Consiglio comunale cuneese almeno dal 1568), Filippo Ferdinando era nipote di Filippo Matteo Grimaldi (1650ca.-1716), prefetto di Cuneo e consigliere comunale quasi ininterrottamente dal 1671 alla morte. Il posto in Consiglio era passato al figlio di Filippo Matteo, Giuseppe Ottavio, il cui ruolo nella municipalità è attestato dal 1717 al 1733. Alla fine del 1727 questi si era appunto rivolto al governatore della città chiedendo la reclusione in fortezza del figlio. «Suivant l’instance[de son père», raccontava al ministro il comandante del forte, il giovane era stato messo in cella «avec deux autres jeunes hommes retenut de mesme nature», incatenato, e con espresso divieto di parlare.
Dagli archivi del 1729 ecco i nomi, le ragioni dell’arresto ed eventuali provvedimenti a carico dei detenuti a Ceva
Condannati per sentenza
- marchese Costanzo Del Carretto di Monforte arrestato per ragioni note al Re
Egli è in libertà di uscire, ma non vuole profittare della grazia, pretendendo, in effetto della sua pazzia, di essere prima ascoltato in un consiglio generale nel luogo di Monforte
- prete Giovan Paolo Garino arrestato per sortilegi
- vedova Anna Roggero, Sua Maestà si crede abbia ordinato che la detta Roggera sia trasportata in un monistero
- Carlo Francesco Cochis, arrestato discolo, è detenuto d’ordine della Maestà Sua ed a spese delle sue finanze, per essere figlio d’una nutrice di Sua Altezza Reale
- Antonio Francesco Colomba, condannato a tre anni di galera per introduzione di sale di sfrozo in Alessandria, commutata poi essa pena da S.M. in quella della prigione ad intercessione del vescovo di Alessandria, oggi arcivescovo di Torino, ed a supplica de’parenti, a spese de’quali è trattenuto
- cavalier Alessandro Magliano condannato alla galera per 10 anni per delitti et indi preso in luogo immune a motivo degli insulti e minacce che vi faceva, principalmente alla di lui madre
I tempi ed le modalità di queste condanne erano spesso pretestuose e l’inasprimento delle condizioni di vita oltre alle pene detentive esagerate peri reati commessi. Così, dando un giudizio sulla situazione non dovremmo dimenticarti di valutare i tempi e l’ambiente storico in cui si svolgevano i fatti. Solo così potremmo averne una seppur parziale percezione. Non c’era nulla di democratico in tutto questo. In fondo all’epoca pochi conoscevano davvero la parola “democrazia”.